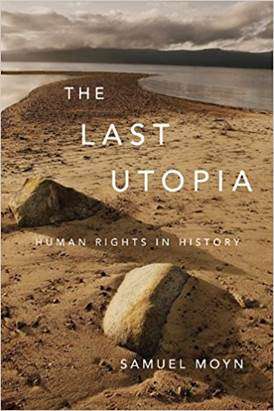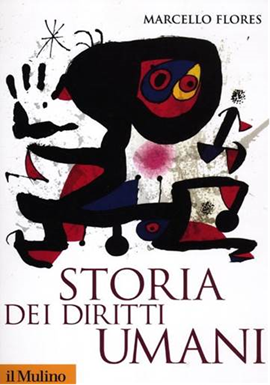A colloquio con il presidente Fabrizio Petri per i quarant’anni del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani
 Quarant’anni fa l’Italia aderiva al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici: veniva istituito così il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) con il compito di assolvere agli obblighi assunti dall’Italia per eseguire e rispettare i vari accordi e convenzioni internazionali che riguardano la protezione e la promozione dei diritti umani espressi dalla Dichiarazione Universale.
Quarant’anni fa l’Italia aderiva al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici: veniva istituito così il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) con il compito di assolvere agli obblighi assunti dall’Italia per eseguire e rispettare i vari accordi e convenzioni internazionali che riguardano la protezione e la promozione dei diritti umani espressi dalla Dichiarazione Universale.
Nel 2018 si è celebrato il 40°Anniversario dell’istituzione del CIDU che ha offerto anche l’occasione di evidenziare il lavoro fatto fino ad oggi per dare un seguito operativo e concreto ai principi sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Nel dicembre scorso è stato conferito al CIDU dall’Università La Sapienza di Roma, Master in Tutela internazionale dei diritti umani, il prestigioso Premio Sapienza Human Rights Award 2018, attestazione del grande lavoro svolto negli anni dal Comitato a tutela e promozione dei Diritti Umani in Italia.
Sin dalla sua istituzione (nel 1978) il CIDU è collocato presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del MAECI. Fanno parte del Comitato trenta rappresentanti provenienti da Ministeri, Amministrazioni ed Enti che a vario titolo si occupano delle tematiche dei diritti umani: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Unicef, dal Ministero della Difesa all’Unesco, dal Ministero dell’istruzione all’Istat e l’elenco sarebbe ancora lungo.
Dal 2016 il presidente è Fabrizio Petri, diplomatico della Farnesina, a cui abbiamo chiesto di spiegarci il ruolo e le competenze del CIDU.
Quali sono gli appuntamenti più importanti su questo tema a livello internazionale?
Attualmente è in corso la predisposizione del Rapporto periodico nazionale alla Convenzione internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale e di quello relativo alla Convenzione quadro sulle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa.
L’Italia dovrà inoltre discutere ad aprile dinanzi alle Nazioni Unite il proprio rapporto alla Convenzione per la protezione dalle sparizioni forzate.
L’impegno più consistente, per quanto ci riguarda, sul piano internazionale nel 2019 è la preparazione della terza Revisione Periodica Universale del nostro Paese, che avrà luogo sempre a Ginevra dinanzi al Consiglio per i Diritti Umani nel novembre prossimo.
Il CIDU ha, fra l’altro, il compito di seguire l’attuazione delle Convenzioni internazionali e la loro concreta osservanza sul territorio nazionale: come si realizza in pratica questa importante azione di monitoraggio?
Il CIDU è responsabile della predisposizione dei rapporti periodici o ad hoc che l’Italia ha l’obbligo di presentare agli organi di monitoraggio delle Organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti umani, come le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa. Esso inoltre rivolge un’attenzione specifica all’attività di Governo finalizzata all’adempimento degli impegni previsti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, verificando l’attuazione delle Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito e la loro concreta osservanza sul territorio nazionale, mediante un sistematico esame delle misure legislative, regolamentari, amministrative e di altro genere adottate dall’ordinamento nazionale.
Come interagite con la società civile e come vengono coinvolte le Organizzazioni non governative?
Nel corso degli ultimi anni il Comitato interministeriale per i diritti umani ha gradualmente intensificato i contatti con la società civile: dalle associazioni delle persone con disabilità a quelle dell’infanzia, da quelle per le donne a quelle LGBTI, dai difensori dei diritti umani alle associazioni per la libertà di stampa, alle associazioni sindacali, etc.; attività che risulta fondamentale per garantire un dialogo sui diritti umani a livello pienamente multi-stakeholder.
Ciò è avvenuto sia coinvolgendo i rappresentanti delle organizzazioni non governative nella raccolta dei dati necessari alla stesura dei vari rapporti, sia organizzando incontri con le principali ONG del settore per un confronto organico e costruttivo sulle linee di indirizzo che il Governo italiano adotta in materia di diritti umani in occasione delle principali scadenze internazionali. Al fine di seguire tali dinamiche e rafforzare i rapporti con la società civile è stata inoltre istituita una figura ad hoc in seno al CIDU.
Nel Piano d’Azione “Donne, Pace e Sicurezza” le donne non sono viste solo come vittime, ma anche come agenti del cambiamento: come si realizza in concreto questo nuovo focus del P.A.?
Premesso che l’Agenda Donne, Pace e Sicurezza si basa sulla Risoluzione ONU, dello stesso nome, numero 1325 del 2000, il nostro Piano Nazionale, giunto alla sua terza edizione, si prefigge di favorire proprio la formazione e la partecipazione sempre più attiva delle donne alle iniziative di mediazione e pace. Sappiamo bene che in questo senso vanno gli sforzi del nuovo Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, di nominare più donne in posizioni apicali per iniziative di riconciliazione e pacificazione. Da parte sua il CIDU, oltre a redigere il Piano d’Azione e monitorarne l’applicazione, porta avanti anche un’azione di comunicazione strategica capillare negli ambienti interessati. A tal fine collaboriamo sovente con organi di stampa ed i medie, a cominciare da RAI Cultura.
In sintesi cosa prevedono i due Piani d’Azione elaborati dal CIDU su “Donne, Pace e Sicurezza 2016-2019”, e su “Impresa e Diritti Umani 2016-2021”?
La terza edizione del Piano d’Azione Nazionale su “Donne Pace e Sicurezza” dell’Italia copre il periodo 2016-2019. È organizzato intorno a 7 Obiettivi, che includono specifici impegni, azioni, indicazione delle Autorità competenti ed indicatori, che riflettono il contenuto delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e gli standards internazionali e regionali sul valore trasformativo che il coinvolgimento delle donne può portare alle situazioni di crisi. Formazione, coinvolgimento attivo, disseminazione di buone partiche, attività di comunicazione ne sono l’ossatura. Il Piano d’Azione è reperibile sia in italiano che in inglese sul sito del CIDU e non mi dilungo pertanto sulle sue disposizioni. Mi preme però sottolineare che vista la sua rilevanza siamo impegnati ad implementarlo con un approccio multi-stakeholder, in stretta collaborazione con la società civile e gli altri attori più rilevanti, che hanno contribuito nel 2018 alla redazione del Primo Progress Report.
Il Piano attualmente in corso ha ottenuto anche un finanziamento pubblico, grazie all’importante azione di sostegno del Parlamento, che ha consentito all’Italia di entrare nel novero, ancora molto limitato, di quei Paesi che assicurano specifico sostegno finanziario pubblico.
Il Piano d’Azione su “Impresa e Diritti Umani 2016-2021”, che sta riscontrando un crescente successo in tutti gli ambienti interessati, da quello imprenditoriale a quello accademico, dalla società civile al mondo sindacale, è molto articolato. Con l’unire impresa a diritti umani si mira a favorire un salto di qualità, innanzitutto culturale, che possa portare il settore economico ad adottare comportamenti imprenditoriali che, pur salvaguardano in pieno la libertà d’impresa, la sappiano coniugare con una visione etica in cui l’essere umano – sia nella sua dimensione individuale che sociale – sia sottratto ad ogni possibile forma di abuso e possa invece, al pari dell’ambiente in cui viviamo, essere salvaguardato nella sua dignità ed integrità.
Il Piano italiano è stato già riconosciuto a livelli di eccellenza, ad esempio dal Danish Institute for Human Rights, per l’attenzione alle categorie di popolazione più vulnerabili (infanzia, donne, migranti, persone Lgbti, disabili).
Voglio segnalare che l’Italia ha appena concluso – primo Paese al mondo – la revisione di medio termine del Piano, avvenuta mediante un intenso processo di dialogo multi-stakeholder, presentata lo scorso novembre al Forum annuale su Impresa e Diritti umani organizzato dall’ONU a Ginevra.
In che cosa consiste l’esame dell’Italia relativamente al Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e come è stata valutata l’Italia in questo importante esame?
Come per tutti i Trattati di rilievo sui Diritti Umani di cui l’Italia è parte, l’esame consiste nella discussione orale dinanzi al competente Comitato ONU dell’ultimo rapporto periodico presentato dal nostro Paese in materia. Va rammentato che il dialogo con i Comitati ONU va visto come un “dialogo costruttivo” che intende favorire una sempre migliore applicazione dei Trattati. In particolare l’esame del sesto rapporto periodico dell’Italia per l’ICCPR si è svolto nel marzo 2017. In tale occasione la sensibilità del relativo Comitato si è appuntata, inter alia, su: il mancato stabilimento della Commissione Nazionale Indipendente per i Diritti Umani; la situazione dei migranti; la situazione dei Rom, Sinti e Caminanti; la introduzione del reato di tortura (poi avvenuta lo stesso anno a seguito del varo di apposita legge); la discriminazione di genere e le problematiche ad essa connesse. Più in generale, con spirito costruttivo, si sono toccate tutte le questioni che discendono dal Patto e le connesse osservazioni conclusive forniscono una guida per l’azione di settore.
Quando il Comitato agisce a livello internazionale diviene più evidente il problema della mancanza in Italia di una Autorità nazionale indipendente basata sui princìpi di Parigi (autorità che hanno invece molti altri Stati): perché è così importante la presenza di una Autorità nazionale? E a che punto è il percorso per il raggiungimento di questo obiettivo?
Con il loro operato le Istituzioni Nazionali Indipendenti per i Diritti Umani concorrono a mantenere viva l’attenzione verso temi fondamentali – come la libertà di coscienza e di espressione, la libertà di credo, la tutela delle minoranze, a cominciare da quelle religiose – che continuano ad essere dibattuti ed aggiornati nel quadro del percorso globale dei diritti umani. D’altra parte simili organismi costituiscono la coscienza critica che aiuta un Paese ad acquisire autoconsapevolezza nella tutela dei diritti, e per tale ragione essi, secondo i famosi “Principi di Parigi” del 1993, devono essere assolutamente indipendenti.
Nella piena consapevolezza dell’importanza per il nostro Paese di dotarsi di un simile organismo – impegno preso dall’Italia anche nel quadro dell’ultima Revisione Periodica Universale – il CIDU, sia attraverso Audizioni in Parlamento, sia collaborando con le organizzazioni della società civile più attente al tema, che infine interagendo con il mondo accademico, ha sempre mantenuto viva l’attenzione su tale argomento e sostenuto le iniziative legislative in tema. Ed anche nella corrente legislatura sono stati presentati vari disegni di legge e che la Commissione Affari Costituzionali alla Camera ha adottato come testo base per il prosieguo dell’esame un testo presentato dal M5S.
Infine mi preme ricordare che nel novembre scorso il CIDU ha organizzato a Trento con la locale Università un importante seminario sul tema, riavviando il dibattito tra i soggetti interessati, e che il prossimo 31 gennaio interverrò ad un altro convegno sul tema presso la Camera dei Deputati, organizzato dagli stessi professori di Trento assieme al Centro Studi di Politica Internazionale (Cespi).
Quale sarà il suo prossimo impegno in Agenda?
Sono appena rientrato dalla discussione a Ginevra del V-VI rapporto periodico dell’Italia relativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dovremo subito curarne i seguiti.
Il CIDU infatti ha anche il compito di svolgere le cosiddette attività di follow-up, tra cui la preparazione delle risposte italiane ai commenti, alle osservazioni ed ai quesiti emersi, formulati dagli organi di controllo istituiti nell’ambito dei principali strumenti giuridici convenzionali in materia di diritti umani.
Poi sarò di nuovo a Ginevra ad aprile per l’esame, come dicevo, del Rapporto italiano alla Convenzione per la protezione dalle sparizioni forzate.
Come intellettuale e studioso della materia quale autore/libro consiglierebbe a un giovane studente per approfondire il tema dei Diritti Umani aggiornato nel contesto attuale?
In lingua inglese: The last Utopia di Samuel Moyn. Sebbene sostenga tesi in parte controverse, fornisce un avvincente affresco sull’affermarsi nel mondo contemporaneo della rilevanza politica dei diritti umani, di cui il 1977, con l’avvio della Presidenza Carter ed il conferimento del Premio Nobel per la pace ad Amnesty International, ha costituito per l’autore un anno di svolta.
In lingua italiana suggerirei, fra i tanti, i libri Storia dei diritti umani (2008) di Marcello Flores, e Storia dei diritti dell’uomo (2015) di Vincenzo Ferrone.
Quanta incidenza hanno le convenzioni o gli accordi rispetto alla mobilitazione della società? La tutela dei diritti umani si garantisce meglio dall’alto o dal basso? (O forse l’una ha bisogno dell’altra….) Esistono esperienze concrete al riguardo?
Più di quanto non si creda. Si tratta di strumenti che contribuiscono alla formazione progressiva del diritto, sia a livello internazionale che nazionale, e come tali costituiscono il punto di riferimento sia morale che normativo per la Società Civile. Resta fermo che è sempre necessario un mix tra lavoro delle Istituzioni e quello della Società Civile per il progressivo affermarsi dei diritti umani. In quest’ottica proprio le Istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani possono, in un dialogo critico con i governi ed i parlamenti, rendere il più vicino possibile alla gente il valore ed il percorso dei diritti umani. E si tratta di valori che toccano la vita quotidiana di tutti noi. A titolo di esempio, la Convenzione sui diritti del fanciullo ha dato corpo al famoso principio del ‘superiore interesse del minore’, che auspicabilmente sta diventando il principio faro in tutti i paesi del mondo per la tutela dell’infanzia. Molta importanza, infine, non bisogna dimenticarlo, ha anche il lavoro svolto dalla magistratura in tutte le sue componenti.
In conclusione quali prospettive future vede per le istituzioni, come quella da lei presieduta, focalizzate sulla promozione dei Diritti Umani ?
Quello che posso dire dal mio osservatorio è che quello dei diritti umani è veramente un cantiere in progress, un percorso senza fine. Bisogna essere consapevoli che occorre sempre difendere i risultati acquisiti e che non si può dare mai nulla per scontato. D’altra parte non bisogna mai scoraggiarsi. Vi sono settori relativamente nuovi, come ad esempio il già citato settore di impresa e diritti umani, in cui si sta registrando un crescente interesse – da ultimo in paesi come India, Giappone, Corea, Tailandia – che fa ben sperare in una crescita di consapevolezza generale.
Infine, il successo che stanno riscontrando gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in cui i tre pilastri delle Nazioni Unite (pace e sicurezza, sviluppo socio-economico, diritti umani) sono per la prima volta trattati in maniera integrata, sono segno di una volontà globale di avanzare verso nuovi traguardi.